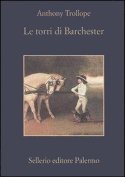La leggenda della morte

Editore
Recensione Utenti
Opinioni inserite: 1
Il prezioso documento di una civiltà rurale...
... lontana ma così vicina
Chiunque abbia visitato la Bretagna sarà probabilmente rimasto affascinato dalla peculiarità che assume l’arte religiosa in quella regione così poco francese. Ciò che colpisce a prima vista è soprattutto l’aspetto popolare dei monumenti e degli edifici religiosi. Le chiese, con l’eccezione delle cattedrali cittadine, presentano in genere architetture nelle quali il gotico, che ne è lo stile dominante, assume forme quasi dimesse: raramente vi è lo slancio verso l’alto tipico dell’ortodossia di questo stile, e molte chiese sembrano semplici case di grigio granito cui siano stati incongruamente aggiunti portali e finestre ad arco acuto. L’interno contrasta ancora di più con i canoni del gotico, essendo in genere luminoso e colorato: le navate sono ricche di statue in legno policromo di santi ritratti con fattezze di popolani, accanto a cui spesso si trovano i simboli dei mestieri di contadino o di marinaio. Ma sono i famosi recinti parrocchiali dei villaggi della Bassa Bretagna, al cui interno troviamo gli splendidi calvari brulicanti di figure scolpite, a segnare l’apoteosi dell’arte religiosa bretone. Nel calvario bretone le croci che svettano verso il cielo sono quasi solo un elemento secondario, perché il vero cuore del complesso è il popolo di figuranti scolpito nel granito alla base delle croci: l’immediatezza, l’ingenua espressività di quelle statue, in cui spesso riconosciamo i tratti degli abitanti di quelle terre, ci restituiscono il senso di un’esperienza religiosa che faceva parte di un sentire comune, cui si faceva riferimento per dare un senso ad una condizione materiale segnata dalla miseria e dalla costante vicinanza della morte, e che esprimeva questa partecipazione collettiva anche attraverso le manifestazioni dell’arte, altrove volta a celebrare una divinità distante e idealizzata. Sembra al visitatore che in questa terra la religione, intesa come insieme di credenze e di regole sociali condivise, abbia giocato un ruolo fondamentale nella definizione dell’identità stessa della popolazione, sicuramente più che nel resto della Francia e in altre regioni rurali d’Europa. Quasi sempre infatti, anche nelle terre che hanno espresso forti sentimenti di religiosità popolare (si pensi al nostro meridione o alla Spagna), questi sono espressi attraverso cerimonie e manifestazioni, mentre l’architettura resta latrice di un messaggio ufficiale attraverso cui la Chiesa spiega al popolo in maniera unidirezionale i propri dogmi. In Bretagna sembra di poter dire che il sentimento popolare abbia partecipato attivamente alla costruzione delle forme attraverso cui tale messaggio è stato costruito.
Questo mio modo di sentire la Bretagna, sino ad ora appoggiato solo su quanto ho visivamente ed emotivamente riportato dai due brevi viaggi compiuti in quella terra, mi è stato confermato dalla lettura di questo bellissimo volume edito ormai una quindicina d’anni fa da Sellerio.
Ne è autore Anatole Le Braz, scrittore e folklorista, ovviamente bretone, vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo. La sua produzione letteraria, non vastissima, si compone di un solo romanzo oltre ad alcuni volumi di racconti e di poesie ambientati in Bretagna, ma soprattutto di opere dedicate alla trascrizione in francese e alla rielaborazione delle leggende e delle storie popolari bretoni. Le Braz in vita fu molto noto in patria, essendo considerato il cantore dell’anima popolare bretone: 'La leggenda della morte', oltre ad essere in assoluto la sua opera più famosa, è anche l’unica tradotta nella nostra lingua.
Il ponderoso volume, di oltre cinquecento pagine, riporta decine di brevi storie, raccolte da Le Braz durante le sue peregrinazioni nei villaggi bretoni, effettuati spesso in bicicletta, che ci restituiscono un vivido affresco del rapporto che la civiltà rurale bretone aveva con il tema della morte.
Come evidenzia molto bene la curatrice del volume, Paola Fornasari, nella prefazione al testo, la morte era molto presente nella civiltà bretone del XIX secolo, come lo era in genere in tutte le civiltà rurali dell’epoca e di quelle precedenti. Il tasso di mortalità infantile era a livelli oggi inimmaginabili (almeno nei paesi ricchi del mondo), si moriva per malattie oggi curabili banalmente o scomparse, si moriva giovani per le fatiche del lavoro; i cimiteri erano in genere ancora al centro del paese, accanto alla chiesa, e anche questo contribuiva a fare della morte un elemento che era, sia pure nella sua drammaticità, paradossalmente parte integrante della vita della comunità. Mentre la modernità ha deciso di risolvere il problema del rapporto con la morte semplicemente esorcizzandola ed occultandola, in quanto negazione de facto del mito dell’efficienza, della produttività e dell’onnipotenza della scienza e della tecnologia su cui si fonda, nelle società rurali e preindustriali il problema della morte doveva in qualche modo essere gestito, perché non era possibile occultarlo. Se la gestione ufficiale del problema era demandata alla Chiesa, che non ha mai mancato di sfruttare questa sua delega, questo suo monopolio della morte al fine di inculcare nei vivi il senso dell’ineluttabilità del destino umano e nello stesso tempo – attraverso i miti della resurrezione e della vita eterna – di rassicurare circa l’inesistenza della morte stessa, esisteva nelle culture rurali un livello più ancestrale di gestione del tema, che a partire probabilmente dal sentimento dell’insufficienza della risposta della Chiesa rispetto all’ingombrante problema, la arricchisce recuperando e rielaborando miti e credenze provenienti dalle epoche antecedenti la cristianizzazione. È di fatto lo stesso schema che porta all’architettura popolaresca di chiese e calvari: alla narrazione ufficiale, perché sia sentita come vera, è necessario associare elementi che derivino dal sentire comune delle comunità.
Il libro di Le Braz, anche nella sua struttura, ha indubbiamente un primario intento scientifico e documentario: egli dichiara infatti di essersi limitato a registrare, mantenendo la loro originalità ed ingenuità, i racconti sentiti di sera, durante le veillées, le veglie comuni accanto al focolare, nelle fattorie bretoni. Lo stesso titolo originale, 'La Légende de la Mort chez les Bretons armoricains' dà l’idea più di un saggio che di un’opera letteraria. In realtà, come fa notare Antonino Buttitta nel lungo e bellissimo saggio posto a chiusura del volume, una serie di elementi provano che le storie riportate ne 'La leggenda della morte' sono il frutto di una, ancorché parziale, rielaborazione dell’autore. Innanzitutto il fatto che all’epoca della raccolta delle storie non esistessero strumenti di registrazione fa pensare che l’autore dovesse necessariamente operare una sintesi di ciò che sentiva, seguita da una rielaborazione a posteriori; è poi indubbio che molte delle storie presentano delle descrizioni dei luoghi e dei sentimenti dei personaggi che non possono che derivare dall’intervento di un autore letterariamente avvertito. Antonino Buttitta analizza compiutamente i rapporti esistenti tra indagine antropologica e letteratura, soffermandosi sulla diversa capacità che questi due strumenti hanno di indagare la realtà e prendendo sorprendentemente partito – vista la sua matrice antropologica – per la letteratura, dicendo tra l’altro: ”Lo scrittore cercando l’uomo trova gli uomini, l’antropologo, ma anche lo storico, il sociologo etc., osservando gli uomini troppo spesso perde l’uomo”. Lasciando alla lettura di questo a mio avviso imperdibile saggio l’approfondimento della questione, da lettore dilettante non posso che notare come l’aspetto letterario di quest’opera di Le Braz , scrittore a tutto tondo oltre che folklorista, contribuisca notevolmente alla sua piacevolezza.
La struttura del libro, come accennato, denota il suo intento documentario: esso è infatti suddiviso in 22 capitoli, ciascuno dei quali è dedicato ad un aspetto del rapporto dell’individuo o della comunità con il mondo dei morti o con la morte stessa. C’è quindi un capitolo intitolato 'I segni premonitori', un altro dedicato a 'Come chiamare la morte su qualcuno', altri a' Prima della morte' e a 'Dopo la morte', altri ancora 'Gli annegati' e a 'Coloro che ritornano' e così via. Ogni capitolo è preceduto da una breve introduzione dell’autore all’argomento trattato ed a come questo si articola nella cultura popolare bretone, seguita da alcune brevi storie, raccolte come detto direttamente dalla voce dei narratori. Ciò che caratterizza queste storie è che per la maggior parte i racconti non riguardano antiche leggende, tempi remoti o personaggi fantastici, ma si riferiscono ad episodi capitati a parenti, a conoscenti – quasi sempre citati per nome e di cui viene indicato il villaggio in cui vivono o vivevano – o allo stesso narratore. L’elemento fantastico, quale può essere il segno premonitore dell’imminente morte o il ritorno di morti che reclamano preghiere per abbreviare la loro permanenza in purgatorio, è in queste storie parte integrante della quotidianità della vita di ognuno, a ulteriore testimonianza di una frequentazione con la concretezza della morte molto diversa da quella che abbiamo noi oggi e nello stesso tempo della necessità, come detto, di gestire la grande contraddizione che la presenza della morte introduce nella vita.
Tra i capitoli a mio avviso più significativi di un libro che lo è complessivamente, uno ci presenta la rappresentazione stessa della morte nella cultura popolare bretone: si tratta dell’Ankou, l’operaio della morte, come ci dice Le Braz nella sua introduzione. Secondo la credenza, l’ultimo morto dell’anno diventa in ciascuna parrocchia l’Ankou per l’anno successivo. Gira di notte per le strade della campagna bretone sotto forma di un uomo scheletrico che guida un carretto cigolante trainato da due cavalli macilenti. Quando lo si incontra, la morte, propria, di un congiunto o di un conoscente, è prossima.
Un’altra figura importante del folklore bretone ruotante attorno al tema della morte è l’Anaon, l’immenso popolo delle anime in pena. Le anime di coloro che devono espiare nel purgatorio i loro peccati circondano i villaggi, vivendo tra i cespugli di ginestre ed entrando spesso nelle case, in particolare di notte: con comportamenti appropriati, legati alla quotidianità, come lasciare un po’ di fuoco sotto la cenere di notte oppure non spazzare le stanze di sera, oppure ancora non fischiare mentre si cammina di notte, è possibile alleviarne le sofferenze. Spesso singole anime si rifugiano nel corpo degli animali, e lanciano messaggi perché i vivi comunichino con loro e favoriscano la loro espiazione. Altre volte sono responsabili di fatti inspiegabili e veri e propri dispetti, che hanno sempre lo scopo di richiamare l’attenzione dei vivi sulla necessità di abbreviare le loro pene. Moltissimi sono comunque i racconti ed i capitoli veramente godibili di questo libro, che lascio alla gioia del lettore.
La natura ibrida di questo libro, a metà tra documento antropologico e opera letteraria, deriva anche dal contesto culturale in cui fu scritto. Siamo come detto verso la fine del XIX secolo: alcuni decenni prima il romanticismo, in particolare quello tedesco, ma non solo – si veda ad esempio l’opera di un grande russo come Odoevskij – aveva per primo teorizzato il recupero della cultura popolare, della spontanea poesia del popolo quale elemento su cui fondare l’identità nazionale. Il recupero della poesia popolare (si pensi ai Grimm ed a 'Il corno magico del fanciullo' di Brentano e Von Arnim) era però avvenuto dall’alto, come rielaborazione letteraria non scevra da manipolazioni di un corpus culturale funzionale ad un preciso disegno ideologico. Il susseguente positivismo aveva posto l’urgenza della sistemizzazione del sapere, della necessità dell’applicazione del metodo scientifico anche rispetto alla conoscenza delle relazioni umane e della cultura popolare. Dall’unione di questi due approcci nasce a mio avviso il fortunato mix di scientificità e di letterarietà di quest’opera di Le Braz, che ne costituisce uno dei fattori di indubbio fascino. Si aggiunga che siamo in un’epoca in cui l’ottimismo razionalista dell’800 è già culturalmente in profonda crisi, e che una delle risposte a tale crisi è l’interesse diffuso per lo spiritismo e il soprannaturale, e si avrà la cornice intellettuale da cui deriva l’opera di Le Braz. Essa è indubbiamente animata da un amore dell’autore per la sua terra e per l’identità di questa, ma non deve essere intesa come operazione culturale rivoluzionaria volta ad affermare la diversità bretone: è invece un’opera soffusa da una certa patina di bonario paternalismo, come emerge anche dal fatto che fu scritta in francese, rivolgendosi quindi più ad un pubblico estraneo alla cultura che descrive piuttosto che ai detentori della fonte di tale cultura.
Nondimeno si tratta di un bellissimo libro, anche perché impreziosito, oltre che dai due saggi citati, da un ponderoso corpus di note che permettono di penetrare in profondità un mondo culturale più vicino a noi e ai nostri portati emotivi di quanto il tempo passato da quando fu scritto e lo spazio che ci separa dalla Bretagna facciano supporre.

 Opinione inserita da viducoli 13 Aprile, 2017
Opinione inserita da viducoli 13 Aprile, 2017