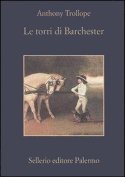Jakob von Gunten

Editore
Recensione Utenti
Opinioni inserite: 2
Come si deve comportare un ragazzo?
Questa è stata la mia prima lettura dell'opera di Robert Walser, scrittore svizzero di gran fama e non a torto. Classe 1878, visse i suoi ultimi ventitré anni, fino al 1956, recluso contro la propria volontà in un istituto psichiatrico per una presunta schizofrenia, diagnosi mai più verificata in seguito.
"Jakob von Gunten" appare nel 1909 in Germania, terza opera di Walser. Scritto in prima persona, è un romanzo di formazione, in cui Jakob va all'Istituto Benjamenta, scuola di domestici, per imparare l'ubbidienza e la pazienza, doti fondamentali per un domestico che si rispetti. Già dalle prime pagine il lettore viene catapultato in questo ambiente strano per certi versi, in cui non si insegnano nozioni ma comportamenti pacati, ascolto, ubbidienza, rinuncia a ogni aspirazione personale se non quella di diventare una nullità e di servire egregiamente una Signoria in futuro. Quello che aumenta ancor di più la stranezza è il fatto che Jakob proviene da una famiglia borghese, colta e ricca, che si avvale essa stessa di domestici. Perché allora Jakob va su questo sentiero umile, sottomesso e con zero prospettive di arricchimento?
La prosa ha molto dello stile colloquiale motivo per cui l'ho trovato molto scorrevole e si sofferma a sottolineare varie tematiche attinenti a "come si deve comportare un ragazzo", che vanno ben oltre all'ubbidienza e la pazienza. Si ha l'impressione di leggere in un certo senso un testamento contenente consigli di vita. Invita il lettore a non essere un chiacchierone, a non essere un arrampicatore sociale, a non essere accecato dal denaro, a non parlare mai dei propri progetti grandiosi che devono sempre compiersi sotto il velo del silenzio, si invita ad amare e si esprime la necessità di essere amati, senza l'amore la vita avvilisce, proprio come la vita della Sig.na Benjamenta ("Io muoio, Jakob, perché non ho trovato l'amore. Questo cuore, che nessun uomo degno ha ambito di possedere, di ferire, se ne sta morendo."). La cosa che mi ha sorpresa in tutte queste perle di saggezza, chiamiamole così, è stato il fatto che l'autore non critica mai, non giudica, semmai compatisce e si ha sempre questo filo rispettoso per tutto e per tutti lungo tutto il romanzo, e questo perché "io amo gli uomini. Amo e apprezzo le loro mattanate e impennate più di qualsiasi prodigio della natura."
Tornando al perché Jakob, ricco rampollo borghese, sceglie questa scuola di mitezza, modestia e sottomissione, prescindendo dal dettaglio autobiografico, io ne ho trovato due risposte. La prima sta nelle sue stesse parole nell'interno del romanzo, ossia nel fatto che per vivere intensamente una cosa, apprezzarla, bisogna sentirne la mancanza, reprimerla:
"Il divieto di piangere, ad esempio, fa più grande il pianto. Ed essere privati dell'amore non significa altro che amare. Se non mi è permesso d'amare, amo dieci volte di più. Ogni cosa proibita vive in misura centuplicata; perciò vive di vita tanto più intensa quello che dovrebbe essere morto. Questo vale per il piccolo come per il grande. E questo sia detto così alla buona, nei termini più quotidiani: ma proprio nel quotidiano stanno le vere verità."
La seconda interpretazione, invece, la trovo nel tentativo di Walser di far vivere ancora un'epoca che ormai è in declino, quello della borghesia che sta splendendo ormai con raggi sempre più deboli e tiepidi, di salvarla in qualche modo mettendosi esso stesso a sua disposizione e servirla- infatti Jakob sarà l'ultimo allievo dell'istituto:
"il modo di fare della del gran signore o della gran dama non è più tollerato. Non ci sono più signori che possano fare quel che vogliono, e da molto tempo non ci sono più grandi signore. Mi devo forse rattristare per questo? Non ci penso neppure. Sono responsabile io dello spirito del tempo? Lo prendo com'è, il mio tempo, riservandomi solo di fare in silenzio le mie osservazioni."
A questo proposito mi viene in mente l'analoga nostalgia di Sandor Marai, che ne è stato un custode dell'alta borghesia e ne ha conservato la memoria in tutti i suoi libri.
La prosa nel suo complesso, nonostante la vena colloquiale si dimostra essere molto poetica, c'è la descrizione della Sig.na Benjamenta che lascia senza parole, ma anche molto profonda e che fa meditare, una prosa a tratti nostalgica ma benigna, amica della vita e degli sentimenti positivi.
Indicazioni utili
Essere uno zero
Per tentare di fare un passo appena nel complesso intrico di significati che potrebbe celarsi nello “Jakob von Gunten”, può essere d’aiuto al lettore un principio cardine della comunicazione e cioè l’impossibilitò di non comunicare. Il cupio dissolvi che anima il protagonista, ben condensato nella volontà di essere niente più che uno zero, costruisce una coreografia letteraria che continuamente si sottrae alle sue conclusioni, come in un continuo movimento della macchina da presa che rifiuta di mettere a fuoco il problema. Sgranato, sfocato, inintelligibile, il cuore impossibile del romanzo si trova in un altrove che esiste solo nella mente del lettore, abituato a indagare significati nascosti, simboli criptici, misteriose associazione. Eppure la verità è che in questo libro i simboli non significano nulla, sono idoli inconsistenti e tutto si radica in un pragmatismo inesausto che vuole condurre il lettore a non interrogarsi, non fare troppe domande. Lo costringe anzi a quello che gli studenti dell’istituto Benjamenta, Jakob in primis, fanno ogni giorno: ripetere a memoria nozioni inutili, studiare e ristudiare gli stessi concetti, occupare la mente per tenere il pensiero a bada. Quale è l’insegnamento che viene impartito nell’istituto? Quale è il segreto che si nasconde nelle stanze interne? Il fatto è che Walser, indefesso prestigiatore, costruisce lo spettacolo e suscita le domande, ma poi non spiega il trucco perché semplicemente non c’è trucco. Al cuore dell’istituto Benjamenta, al centro dell’esperienza di Jakob, non c’è nulla. Uno zero assoluto. E su questo vuoto si spalanca il libro.
Robert Walser è considerato uno dei più grandi autori svizzeri di lingua tedesca insieme al suo connazionale Dürrenmatt. Ha scritto migliaia di pagine, costellazione di microstorie che tentano di ricostruire un disegno e che allo stesso tempo demoliscono ogni possibilità di disegno. Non credo sia un caso che Walser fosse un autore molto amato da Kafka, che amava molto lo Jakob von Gunten e che nel suo “Il castello” recuperò l’idea di uno spazio geografico chiuso, il castello-istituto, che sfugge ad ogni semplice simbolismo o facile metafora. L’istituto Benjamenta non è né la vita, né la crescita, né un subdolo grande fratello, è piuttosto uno spazio indifferenziato in cui il pensiero lotta per negare se stesso, in cui la prassi è potenza di negazione. Walser passò ventotto anni in una clinica psichiatrica, distrutto, stanco come una stufa spenta e più volte ebbe a dire che nessuno poteva davvero pretendere di conoscerlo. E allora tutta l’enigmaticità delle sue opere, i significati reconditi, le interpretazioni più svariate, il vuoto cupo che lasciano al lettore, sono forse gli estremi esiti di chi sa che non c’è nessuna verità possibile, che il fondo delle cose è uno zero assoluto. E la manciata di vuoto con cui il lettore resta in mano è la voce di chi non ha saputo essere capito.
Detto questo, il romanzo in sé procede in modo del tutto particolare, abbastanza fastidiosamente, lo stile è quasi infantile, ma molto studiato, i temi accennati e mai analizzati. Resta un senso di inconsistenza, come se di tutto non fosse rimasto niente, ancora uno zero assoluto e allora l’unico modo per capire è analizzare il negativo del libro. Eppure il negativo del libro non basta a renderlo una lettura del tutto soddisfacente.