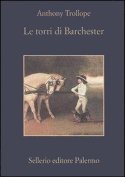Gli ambasciatori

Editore
Recensione Utenti
Opinioni inserite: 1
UN AMERICANO A PARIGI
Durante la lunga, impervia e faticosa lettura de “Gli ambasciatori” mi è stato di grande utilità tenere presente, quasi come un faro segnalatore, un altro romanzo di James, per quanto apparentemente antitetico per dimensioni, struttura e impianto narrativo. Il Lambert Strether, che dall’America giunge in Europa per “recuperare” alla famiglia e alla carriera il rampollo che a Parigi, incurante delle ingiunzioni materne, si dice stia conducendo una vita dissipata, assomiglia infatti per molti versi al protagonista de “La belva nella giungla”. Come quest’ultimo trascorre tutta la vita cercando di mettersi al riparo dal terribile colpo del destino che fin dall’infanzia è sicuro di essere destinato a subire, senza riuscire, a causa del suo egotismo, a comprendere, se non quando è ormai troppo tardi (cioè dopo la morte dell’amica devota), che questo colpo gli è già stato inferto a sua insaputa, così Strether si destreggia nella sua missione senza mai raccapezzarsi del tutto su quale sia la reale situazione che lo vede coscienzioso o riluttante attore in una parte che non afferra mai del tutto. L’idea geniale di James è quella di fare di Strether l’unico depositario del senso del racconto, e proprio a causa della sua ignoranza rendere il romanzo, che pure verte su una storia quanto mai semplice e prosaica (il giovane Chad è diventato l’amante della matura e raffinata Madame de Vionnet), un concentrato di ambiguità, misteri, doppi sensi e oscurità: insomma, quasi un romanzo giallo a comprensione ritardata. Gli interlocutori di Strether, lasciando sempre le loro rivelazioni a metà, alludendo senza mai pronunciarsi apertamente, riempiendo le loro affermazioni di ulteriori possibili significati, fanno rimanere il protagonista (e con lui il lettore) sempre un passo indietro rispetto alla realtà dei fatti. James prende sottilmente in giro l’educazione perbenista dei borghesi americani che, per rispetto dell’etichetta, buona educazione e pruderie, hanno l’abitudine di vedere le cose in maniera per così dire eufemistica (è esemplare “l’attaccamento virtuoso” che Strether attribuisce alla relazione tra i due amanti, ignaro della sua fin troppo prevedibile natura erotica e sensuale), anziché nella loro cruda e banale verità, e così facendo rimangono desolatamente all’oscuro delle cose stesse, facilmente manipolabili dagli altri, quando invece dovrebbero essere loro, per cultura, età, esperienza e responsabilità, a manovrare, dirigere e convincere. Strether è un uomo di tale fattura, e in più è un uomo che si accorge troppo tardi di non avere vissuto realmente la vita, di averla sprecata malamente. L’impatto con Parigi ha per lui l’effetto devastante di un innamoramento senile, e per giunta un po’ patetico, in quanto la gioventù “bohemienne” che tanto lo affascina lo fa sembrare, per quanti sforzi faccia per adeguarsi alla disinvolta vita della “Ville Lumière”, un paludato e antiquato rappresentante di un mondo ormai sorpassato. Ancora una volta i due poli opposti dell’universo jamesiano – l’America e l’Europa – ingaggiano una battaglia dialetticamente complessa che ha Strether come simbolica posta in palio e i cui alfieri risiedono forse in due personaggi secondari del romanzo: Waymarsh, l’amico di Strether che rifiuta sdegnosamente di venire a patti con la cultura e le abitudini del Vecchio Mondo, da una parte, e la signorina Gostrey, la disinvolta confidente del protagonista, perfettamente a suo agio nella eccitante vita di Parigi, dall’altra.
Maria Gostrey mi offre l’occasione di parlare di un altro aspetto di Strether: la sua disinteressata lealtà, la sua servizievole fedeltà, la sua innocente buona fede. Egli arriva al punto di compromettere il suo futuro e la sua sicurezza economica mandando a monte il suo fidanzamento con la signora Pocock pur di non rinnegare la promessa di aiutare Madame de Vionnet, al cui fascino egli è palesemente sensibile. E sia di fronte a Sarah Pocock, alle cui influenti pressioni rifiuta scandalosamente di sottomettersi, sia di fronte a Chad, che minaccia di maledire se mai dovesse un giorno abbandonare la donna più vecchia di lui che lo ama, Strether si erge a donchisciottesco paladino dell’amore e del “carpe diem”, pur sospettando larvatamente di essere stato più volte ingannato o adescato in una trappola da chi ha approfittato con astuzia della sua anacronistica e idealistica purezza. Sotto un diverso angolo di visuale, bisogna però rilevare che Strether è tutt’altro che l’eroe di questa storia. Con questa considerazione, che passo adesso a motivare, si viene a toccare il punto di massima convergenza con il protagonista de “La belva nella giungla”. Impegnato con tutte le sue forze nella sua complessa missione “diplomatica”, Strether infatti intreccia una delicata amicizia con Maria Gostrey, la “donna di mondo” che prima gli fa da anfitrione e poi da confidente delle sue scoperte. Maria è sempre defilata e in disparte (ad un certo punto, inaspettatamente, si allontana dalla capitale per alcune settimane, ma solo – si scoprirà più tardi – per non condizionare l’amico in occasione del suo incontro con Madame de Vionnet), però – un po’ come l’amica del protagonista de “La belva nella giungla” – è sempre al fianco di Strether quando questi ha bisogno di qualcuno che lo rassicuri, che lo consoli o anche solo che gli faccia un po’ di chiarezza nei suoi dubbi e perplessità. Maria è evidentemente innamorata di Strether, ma il narcisismo e l’egotismo dell’uomo fanno sì che questi si accorga della cosa solo all’ultimo, quando ha già deciso irrevocabilmente di tornare in patria. Di fronte alla decisione di Strether di non voler ricevere (proprio come un “ambasciatore”) alcun vantaggio dalla sua avventura, e quindi di rinunciare alle sincere profferte di Maria, la donna è costretta a rimanere sconsolatamente sola come l’eroina di una tragedia greca. Maria assurge così nelle ultime pagine, imprevedibilmente, a un ruolo deuteragonistico, più di Madame de Vionnet, la quale pure, dopo avere dato tanto a Chad (Strether la ritiene non a torto l’artefice del suo stupefacente miglioramento) vive nella paura di essere lasciata dal più giovane amante. Maria non può neppure aggrapparsi al conforto del ricordo della passione. Essa è malinconicamente condannata a vivere come una vedova senza avere prima gustato le gioie del matrimonio, sconfitta dalla probità morale maschile che mai come in questo caso assume la parvenza di una insopportabile violenza, ammantata com’è di fanatismo, di superbia e di egoistica affermazione del proprio io, anche (o soprattutto) quando vuole apparire come un disinteressato sacrificio. Grazie a questo commovente ritratto, che James cesella con il suo solito penetrante acume psicologico (in una narrazione abilmente dissimulatoria in cui prevalgono i dialoghi a due i quali, anziché aiutare la comprensione - come già affermavo più sopra - la rendono ancor più difficoltosa e ambigua), grazie a questo ritratto – dicevo – Maria entra nella indimenticabile galleria di sfortunate eroine (tra le altre la Daisy Miller dell’omonimo racconto e la Isabel Archer di “Ritratto di signora”) che lo scrittore americano ha condannato, nonostante le loro prodigiose doti di intelligenza, avvenenza e “savoir faire”, a soccombere nella crudele resa dei conti con la vita e con l’universo maschile.