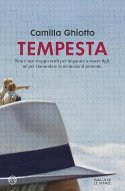Lettera alla madre

Letteratura italiana
Editore
Recensione della Redazione QLibri
Cara mamma
È una lunga, sofferta, a tratti straziante lettera quella che la nota scrittrice di origine ungherese Edith Bruck affida a queste pagine destinate idealmente alla propria madre ormai persa, al pari di milioni di vittime innocenti, nell’indicibile inferno dell’Olocausto sullo sfondo degli anni del secondo conflitto mondiale. Una lettera che, da monologo, sembra farsi via via dialogo dai toni sempre più serrati e intimi tra due persone – madre e figlia, per l’appunto – il cui legame sia stato, bruscamente e brutalmente, interrotto per sempre.
Apparsa già sul finire degli anni Ottanta e ripubblicata da La nave di Teseo all’inizio di questo 2022 con una breve nota introduttiva firmata dall’autrice stessa oggi più che novantenne, l’opera in questione non è un romanzo, come si potrebbe pensare stando a quanto riportato in copertina; non si tratta infatti di narrativa nel senso più classico del termine, non è “fiction” ciò che viene raccontato, semmai una prosa di carattere senza dubbio autobiografico in cui la fantasia deve farsi da parte a favore di una realtà nuda e cruda che ancora oggi atterrisce, ma della quale occorre conservare memoria.
“Come si faceva a diventare così presto nemici anche fra noi e tirare un sospiro di sollievo quando toccava all’altro seguire il selezionatore? […] Tutta la nostra speranza era di trovare qualcosa da mangiare, un boccone non troppo magro e non troppo marcio tra i rifiuti. Per sopravvivere, mamma, bestie feroci, altro che pensare a nostra madre! Non mi chiedevo più nemmeno se eri morta o se eri viva. Non sentivo più altro che fame. Non desideravo altro che mangiare […]”.
L’esperienza terribile vissuta ad Auschwitz e in altri campi di concentramento, nonché l’esserne superstite e testimone, ha segnato la vita della Bruck e di ciò parla buona parte di questo testo; in esso, però, trova spazio anche il rapporto con la propria identità ebraica, nella quale confluiscono lingua, religione, fede che hanno continuato nel tempo a essere problematiche, in verità fin dall’infanzia, prima ancora che la famiglia venisse sradicata a forza, nel ’44, dal suo piccolo villaggio in Ungheria.
“Non so, mamma, perché vivo proprio io e non tu che avresti pregato per tutti?Per me eri tu la fede […]”
Come ne “Il pane perduto”, uscito lo scorso anno sempre con la medesima casa editrice, anche in questa Lettera ci s’imbatte nel ritratto di una figura materna troppo spesso dura e in apparenza poco amorevole nei confronti dell’Edith bambina. Una donna chiusa nelle proprio rigido credo di ebrea osservante che non perdeva occasione per rimproverare quella figlia dall’animo sognatore che lei stessa si chiedeva da dove fosse giunta, tanto si mostrava diversa dagli altri, e che, invece di pregare, amava già allora leggere poesie e “cose inutili”.
“Ah, mamma, senza la poesia, senza l’arte la natura, la vita sarebbero insopportabili, l’aria irrespirabile. Tu non sai quanta verità può contenere un solo verso, una sola parola.”
Ecco, quindi, che l’Edith adulta, ripercorrendo quelle memorie familiari lontane ormai decenni, all’interlocutrice confessa con candore – lei che mangia quel che è proibito e non sa tenere a mente le date delle feste comandate – le sue mancanze in fatto di osservanza religiosa e ribadisce la ferma convinzione delle sue scelte di vita. Il dolore interiore di chi scrive è palpabile, affiora tra le righe a più riprese, così come il desiderio bruciante, rimasto tale, di un’approvazione e un amore da parte materna liberi da condizioni unilaterali.
“Come avresti vissuto tu il dopo, mamma? Avresti ancora pregato? […] Noi due avremmo litigato sempre? Tu non mi avresti mai approvato in niente, io avrei fatto ciò che ho fatto soffrendo il doppio. Non mi rivolgeresti più la parola come da piccola. Ed era peggio dei rimproveri, delle minacce, di qualche scapaccione o schiaffo per colpa mia, perché l’avevo provocato io, no? Nei tuoi silenzi c’era qualcosa di cattivo. Di pericoloso. […] Mi addossavi tutti i tuoi guai di madre, di moglie, di ebrea. Dietro la tua bocca chiusa per me c’erano cinquemila anni di storia brutta.”
Quel “dopo”, purtroppo, non ha avuto possibilità di aver luogo e il loro rapporto pieno di contrasti non ha potuto avere alcuna evoluzione, né in un senso né in un altro. Non resta, dunque, che l’amarezza del rimpianto per l’amore non ricevuto, o comunque molto diverso da quello bramato. A cornice di tutto ciò, non mancano considerazioni sull’essere ebrei in generale e israeliani in particolare; le parole verso Israele e ciò che lo Stato ebraico compie non sono tenere, al lettore trarne le proprie conclusioni.
Attraverso una prosa di notevole profondità che è probabile sia stata infine catartica, Edith Bruck ci consegna un’opera molto bella (pur nella indubbia drammaticità dei suoi contenuti) che da subito coinvolge e merita di essere letta. I morti chiedono pace, allo stesso modo i vivi chiamati a seppellirli seppure non fisicamente; in questo caso, a dare occasione di riconciliazione con il passato è la scrittura stessa, ancor prima delle parole rituali del Kaddish conclusivo.