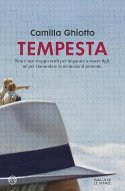Il Romanzo della Nazione

Letteratura italiana
Editore
Recensione della Redazione QLibri
il sogno di un romanzo
“Questa è una storia di gente viva,
viva davvero, intendo.
È la storia di una Nazione che è morta,
morta sul serio, voglio dire”.
Iniziare un libro con questa premessa è stato per me molto accattivante: si ha l’ aspettativa che un romanzo con un titolo così importante aiuti, attraverso una storia, o si spera attraverso la Storia, in questo caso d’Italia, a orientarsi tra le contraddizioni del nostro presente.
Mi ritrovo a leggere una storia personale che, prendendo l’avvio da un lutto recente, ripercorre la storia di una famiglia proletaria e con essa di una terra, la Liguria, che non fatica a travasarsi in Italia intera.
Leggo insomma la storia di Maurizio Maggiani e con la sua la mia: terre diverse, nomi diversi, un padre e una madre però incredibilmente uguali ai miei, non tanto nella loro storia individuale che in quanto tale, altro da sé non può essere, quanto nel loro ruolo, nella loro vita, nelle loro ambizioni, nella loro crescita, nelle loro evoluzioni e involuzioni. La storia della famiglia è davvero gradevole e presenta personaggi interessanti sotto il profilo umano, il figlio che scrive mi pare invece controverso: di squisita ironia, mi ha fatto sorridere in più frangenti, alcune volte sopra le righe e perennemente adirato (?) per cui i concetti vengono sostituiti da più facili - e di impatto - parole sconce, altre volte un po’ troppo autocelebrativo, involuto in se stesso e perfino ambizioso.
Vuole scrivere il romanzo della nazione e “Il romanzo della Nazione” diventa la cronistoria di questo suo tentativo che io, personalmente, mi aspetto erompa da qualcuna delle trecento pagine, prima o poi. Quando penso di esserci finalmente arrivata, la delusione è grande nel capire che mi si offrono i tentativi fatti nel tentativo di scriverlo! Da allora in poi mi trascino nella lettura e neanche il Risorgimento italiano o la Belle Epoque o la storia dell’Arsenale Militare di La Spezia mi incuriosiscono più.
Opera pertanto difficile da catalogare, manca la prospettiva del romanzo, manca la prospettiva della storia, tutto è accennato e riversato in queste pagine di cui ho apprezzato solo i ritratti di famiglia, belli e veri.
La funzione di bussola, di cui accennavo all’inizio, ovviamente non sussiste e forse era questo l’intento.
Indicazioni utili
- sì
- no
Recensione Utenti
Opinioni inserite: 2
Top 500 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Romanzo incompiuto di una nazione incompiuta
Maggiani fonda la sua ultima fatica letteraria sul mito della nazione, che non è lo stato e nemmeno il popolo, ma una comunità di uomini e donne che accettano di mettersi insieme e di stabilire un vincolo collettivo fatto di condivisione e di solidarietà, mettendo a disposizione degli altri impegno, competenze, sacrificio, lavoro. Per questa via, lo scrittore si immette nel solco di un filone letterario, e non solo, ben radicato nel comune sentire postunitario, quello che denuncia il tradimento delle speranze risorgimentali, e che da Carducci (“Oh non per questo dal fatal di Quarto/ Lido il naviglio de i mille salpò”) arriva, attraverso il Pirandello de “I vecchi e i giovani”, al “Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa. Anche un medico dell’arsenale di La Spezia, Enrico Farina, prima di morire –racconta Maggiani- fa in tempo a spedire al Regio Parlamento una memoria sulle condizioni della classe lavoratrice, accompagnandola col medesimo grido di delusione per le speranze troncate: “Non è questa l’Italia ch’io sognava”. E la stessa frase pronuncia Garibaldi quando, in visita allo stesso Parlamento, vede i deputati in marsina e riconosce tra loro molti di quelli che qualche anno prima avevano combattuto con lui in camicia rossa. Le simpatie anarchiche dell’autore si collocano sulla medesima lunghezza d’onda e lo avvicinano al repubblicanesimo mazziniano, lo inducono a soffermarsi sullo scontro a distanza tra le due figure antitetiche di Mazzini e Cavour, parteggiando ovviamente per il primo, a studiare e trasmettere molteplici storie di mazziniani e garibaldini, a raccontare aneddoti poco noti su Garibaldi, a tessere l’apologia della Repubblica romana e della sua costituzione, basata sul principio che la sovranità non è del popolo, ma è nel popolo. In questa ottica, il luogo di massima concentrazione semantica del racconto è proprio l’arsenale di La Spezia, dove il nascente stato italiano riunisce i tecnici, i lavoratori, gli esperti dei più svariati ambiti per costruire la "Dandolo", la più grande corazzata della sua flotta militare. Qui ufficiali ex borbonici che venivano dall’accademia militare della Nunziatella, ingegneri, esponenti della tecnocrazia sabauda, artigiani qualificati ed abilissimi, marinai di straordinaria perizia, ma anche morti di fame degli Appennini, ergastolani, perfino rivoluzionari ricercati dalle polizie di tutta Europa e qui marcati stretto, ma tollerati, condivisero per anni il sogno di una grande costruzione comune, che stabilì tra loro un legame più potente di qualsiasi ordine costituito. Li ritroveremo tutti uniti nel festeggiare il varo della nave, ma anche nel fronteggiare la terribile epidemia di colera con la quale questa straordinaria esperienza comunitaria si esaurì nel segno di un ormai consolidato spirito di solidarietà. Quello che altri stati come la Francia con la rivoluzione e gli Stati uniti con la guerra di secessione riuscirono a compiere, da noi balenò solo a sprazzi, senza mai concretizzarsi, ora con la grande epopea della Repubblica romana, ora con la microstoria dell’arsenale spezzino. Fallimentare fu invece la fondazione dello stato unitario: del resto, come poteva costituirsi in nazione –si chiede l’autore- uno stato nel quale votava solo il due per cento della popolazione, su basi censitarie? E come poteva restare senza conseguenze la decisione del re di non aggregare all’esercito sabaudo, con pari dignità, le truppe garibaldine, che pure gli avevano portato l’inaspettato dono del Meridione? Certe assenze di generosità e di lungimiranza si pagano e pesano, nel tempo, sul destino di tutti.
Fonte primaria di documentazione è, per l’autore, il padre, combattente ad El Alamein, quindi partigiano e comunista. Un fondatore potenziale di nazioni, elettricista, innamorato della scuola, convinto della necessità di una buona istruzione, perfino, in segreto, poeta d’amore ispirato da una moglie anaffettiva, coniatore di quell’aforisma “Vivere di sogni è un’utopia” che il figlio ritrova tra le sue carte e sul cui reale significato si arrovella continuamente, facendone il filo rosso che lega tra loro le vicende dei suoi fondatori potenziali di nazioni. Un ritratto che si conclude con un’altra “morte del padre”, dopo quella raccontata da Saverio ne “Il coraggio del pettirosso”: lì, a causarla, era un ritorno di fiamma per la patria lontana, solo in apparenza dimenticata, ed il gesto inconsulto di una traversata a nuoto impossibile. Qui invece assistiamo ad un tenero tramonto, fatto di oblii, ma forse anche di un rapporto recuperato e intensificato tra padre e figlio, in una casa di cura, dove la malattia non sembra spegnere, ma rinsaldare i vincoli dell’umanità e della pietà filiale. E però, poi, che tristezza quel funerale lungo una strada vuota, nessuno degli amici e compagni a dargli l’estremo saluto e tutto che finisce in un terribile nulla. E’ che il mito della nazione, come tende inesorabilmente a dilatarsi al di là dai confini nazionali, oltre il senso stretto che la storiografia gli assegna, fino a identificarsi con una sorta di utopia anarchica, così è costantemente attraversato, nel romanzo, da una malinconia esistenziale che contrappone, alle speranze e agli entusiasmi, il senso di un vuoto ricorrente, più esistenziale che storico-politico. Un’altra “nemica della nazione” è, su un fronte diverso, Adorna, la madre schiva, determinata, implacabilmente chiusa nella sua dimensione familiare e verrebbe quasi da dire familistica. Ma questo non impedisce all’autore di raccontare di lei con verve affettuosa e divertito distacco, come quando la sua idea fissa che dietro ogni disgrazia ci sia sempre qualche donna (“Ghe de mezzo quarche d’una”) la porta a concepire assurdi sospetti sulla morte di Togliatti. La mano è felice anche quando tocca tutti gli altri componenti di quest’universo familiare contadino, premoderno, prestatale, nel quale non è assente, nei personaggi delle prozie, la componente magica studiata da Ernesto De Marino in altre aree geografiche: un caleidoscopio indimenticabile, all’interno del quale il colore più intenso e toccante è quello della nonna Anita, che esprime nel gesto di tenere chiuse a pugno le mani il dolore della malattia e la consapevolezza del declino e di non poter essere più, per il nipote e per tutti gli altri, il solito-solido rifugio di sempre.
Lo scrittore mostra infatti una straordinaria capacità di ritrarre personaggi, tenendosi miracolosamente in bilico tra controllo razionale e abbandono emotivo, lirismo e ironia: una nota davvero tutta sua, una cifra personale che ha nel linguaggio un adeguato corrispettivo formale, a cominciare dall’espressione dialettale, riportata frequentemente, ma non incorporata nel tessuto linguistico, salvo alcune scelte lessicali selezionate dal registro basso e colloquiale. Frequente, talora spiazzante, l’anacoluto, che trapassa, come avviene nei grandi scrittori, da anomalia sintattica a strumento espressivo. Ad esso si affianca spesso la struttura a ripresa, per cui una frase si appone alla precedente, riprendendone una parte, in genere quella conclusiva, e contribuendo così a dilatare il pathos narrativo. Il periodare, elegante e lessicalmente vario e preciso, tende al paratattico e si fa quasi concitato nei momenti di maggiore empatia, fino a ridursi talvolta ai soli elementi essenziali e ad assecondare la modalità di uno stile nominale, dietro il quale si coglie una propensione incessante a dialogare con le figure ritratte, indulgendo ai sentimenti più teneri della compassione e della pietà. Vicende e personaggi arrivano allo scrittore, in parte, dalla esperienza diretta, più spesso dalla testimonianza orale, fonte primaria della costruzione romanzesca, senza trascurare la documentazione storica, le carte, purché esse “cantino”, o meglio l’autore sappia farle cantare, riscattarle cioè dalla loro funzione meramente documentaria e vivificarle con le proprie emozioni (un difficile equilibrio tra ricostruzione romanzata con forte impronta soggettiva e fedeltà alle fonti, che ricorda Emmanuel Carrère).
Tra personaggi pubblici e politici da una parte e componenti del microcosmo familiare dall’altra, il romanzo ondeggia, privo e volutamente incapace sia di avere un centro sia di trovare una conclusione.
Già l’incipit ne era una spia: “Avevo in mente di scrivere il Romanzo della Nazione, questa era la mia ambizione, ma disgraziatamente lo scorso inverno è morto mio padre. Mio padre era la fonte principale di documentazione, il serbatoio dove erano conservate le spoglie della Nazione. Lo scrigno. E’ un’ambizione quella del Romanzo della Nazione che ho nutrito per un decennio […]. Ma di fronte alla morte anche il proposito più saldo vacilla. Sfido io”. Sembra dunque che non solo la nazione ma il romanzo stesso della nazione sia irrealizzabile.
Questo mancato compimento, questa insuperata impasse, trova il proprio omologo formale in un altro aspetto fondamentale della struttura e della scrittura stessa, che sono divaganti, continuamente attratte lontano dal centro, fino ad arrecare una qualche irritazione al lettore, il quale deve però ben presto rassegnarsi all’evidenza: questa forza centrifuga è l’anima stessa del libro e muove da un bisogno incoercibile di captare, raccogliere, ascoltare, documentarsi, riferire, raccontare. Storie proliferate da altre storie, piccoli dettagli che spostano continuamente il focus narrativo da un personaggio all’altro, da una vicenda all’altra, perfino abbozzi di altri romanzi rimasti in germe e mai compiuti. Piacere a tratti puro di una sempre coinvolgente affabulazione, che si ripete fino alla fine, lasciando nel lettore la tipica sensazione di una struttura aperta e la convinzione che essa si possa dilatare all’infinito: ecco dipanarsi l’una dietro l’altra, l’una nell’altra (ma è solo un esempio) le storie di don Giovanni Verità, che salva Garibaldi prendendoselo in spalla e resta ad “assisterlo” in punto di morte, lui odiatore di preti, col suo ritratto, nella casa di Caprera; del vecchio maestro di scuola repubblicano che si vede recapitare, in mezzo alle montagne in cui vive isolato dal mondo, ogni mattina, il “Resto del Carlino” da un misterioso aviatore; del professor Vitaliano, collezionista di tutti i bollettini della sezione internazionale del Comitato centrale del partito comunista cinese, uno dei quali dedicato ai libri che Mao teneva nel suo zaino durante la Lunga Marcia: la “Divina Commedia” di Dante, “Il Principe” di Machiavelli e un estratto de “La rivoluzione italiana “ di Carlo Pisacane, tre italiani a fare compagnia al grande mito rivoluzionario di un tempo che fu... Ma qualche pagina prima una analoga fecondità narrativa era scaturita dalla ricerca dell’amico Nino sulla figura del nonno, Menotti Serra, e dalla indagine che egli decide di compiere con la figlia Anna sulle tracce dello zio ucciso dai partigiani, nell’intento di dargli sepoltura (e di qui il richiamo a una storia più alta, quella che vede contrapposti, in Antigone e Creonte, la legge degli dei e la legge degli uomini, cioè, nei termini dell’ideologia di Maggiani, la nazione e lo stato: l’ennesima divagazione con la quale, quasi trascendendo la impostazione ideologica del romanzo, l’autore finisce con l’ammettere la necessità storica dell’ordine statuale, pena il caos, come avevano intuito gli stessi Greci).
Questa sorta di bulimia narrativa nasce dalla convinzione che ognuno di noi sia un romanzo e ogni vita una storia che aspetta di essere raccontata e liberata dall’oblio.
Per questo, sembra dire l’autore, il suo racconto dovrebbe fare come da stimolo ad un’impresa collettiva, unirsi e fondersi con tanti altri, con tutti gli altri che ne verranno di conseguenza, per recuperare tutta intera una memoria condivisa, senza la quale il sogno della nazione resterà per sempre tale. La nazione e la sua epopea sono, in definitiva, due aspetti inscindibili e, sembra di comprendere, l’una non può esistere senza l’altra.
In uno degli episodi più accattivanti del romanzo, un importante critico letterario invita il romanziere ad un convegno e gli fa recitare un brano. Lo ritiene il migliore esempio di postmoderno in Italia. Ma un accademico lo stronca, citando l’uso che ha fatto della parola “uccelletto” come testimonianza di un linguaggio obsoleto e improponibile. Ebbene, in questa disputa, non si può non schierarsi dalla parte dell’autore e del suo sostenitore.
Indicazioni utili
L'Italia e la corazzata Dandolo
Un titolo emblematico che Maggiani vuol dedicare all'Italia,alla nazione agognata e desiderata e che non si è mai realizzata così come avrebbe potuto. Intrecciate in questo romanzo le storie familiari dello scrittore con quelle del personale, tra cui suo padre, che lavorava al Regio Arsenale di La Spezia tra '800 e '900. Nasce in quel periodo il progetto di costruire la "Dandolo" la corazzata più potente del mondo, le mestranze arrivavano da tutta Italia, e Maggiani è abile a collegare le aspirazioni, i sogni e le aspettative delle persone che si prodigarono nella costruzione della nave , e soprattutto le brame e i desideri di una nazione intera che sembrava poter ambire a un futuro di dominio e che invece poi..
Concludo estrapolando un passaggio in cui l'autore parla della differenza tra il legame che un figlio può avere con un padre rispetto alla madre(p21):
...""una madre te la porti dietro dappertutto.Un padre sa essere un bravo inseguitore , l'occhio di Dio che insegue la sua creatura prediletta fino in capo al mondo....la madre la creatura prediletta se la porta con sé, incistata nelle interiora più profonde, nelle terminazioni nervose, nel midollo delle ossa, nei coni e nei bastoncelli della retina. Alla madre non servono neppure gli occhi , per scrutare e indagare e spiare le bastano gli occhi di suo figlio""...
Penna profonda quella di Maggiani, bravo