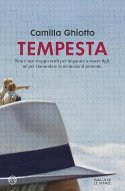Il carcere

Letteratura italiana
Editore
Recensione Utenti
Opinioni inserite: 1
La gelosa solitudine di Stefano
Intimo, profondo, commovente. Il carcere è una sorta di malinconico valzer nel quale si “balla” al fianco di Cesare Pavese. Non sono i fatti che rendono questo romanzo breve così incisivo, ma sono le riflessioni, gli stati d’animo, i silenzi del protagonista, Stefano. Pavese racconta in terza persona l’esperienza autobiografica della condanna al soggiorno obbligato a Brancaleone Calabro per aver cercato di proteggere la donna amata, militante del Partito comunista italiano. E così il confino dell’ingegnere Stefano diventa metafora di una condizione esistenziale di solitudine, metà condanna metà alibi del suo chiamarsi fuori dal mondo, a guardare la vita «come dalla finestra del carcere». L’ingegnere è un intellettuale che imputa a se stesso più che al mondo la responsabilità della propria situazione, rifiutando di riconoscere una qualche giustificazione politica al suo soggiorno a Brancaleone Calabro proprio nel periodo di maggior consenso degli italiani al regime fascista, tra la guerra d’Abissinia e quella di Spagna.
Bisogna ricordare che Il carcere è stato pubblicato da Pavese solo nel 1948, due anni prima del suicidio. È stato pubblicato insieme a un altro romanzo breve o racconto lungo, La casa in collina, libro che ha come protagonista Corrado, sotto il titolo comune Prima che il gallo canti di trasparente allusione. Questa storia di privata solitudine ha un oggetto emblematico: la valigia. Stefano non la disfa mai durante i mesi di confino, la tiene sempre a portata di mano perché da un momento all’altro potrebbe essere mandato a casa e vive nell’angoscia di non fare in tempo a prepararla. Traspaiono, inoltre, le differenze economiche, sociali e culturali tra il Nord e il Sud Italia. Il meridione viene affrescato come un territorio più povero rispetto al settentrione. Le occhiate alle donne al Nord «non bruciano», come dice Stefano, mentre a Brancaleone Calabro scottano e sono quasi proibite.
Il grigio è il colore che trionfa durante la lettura de Il carcere: l’ambiente, i personaggi e lo scorrere del tempo sono avvolti da questo velo che riflette le sensazioni di Stefano. Quel carcere volontario lontano da casa era ritenuto ben peggiore dall’altro, quello vero, che aveva provato prima del confino, tanto che il protagonista solamente da una finestra o da una soglia amava goder l’aria aperta. La penna di Pavese è, come sempre, sensazionale quando deve penetrare nell’animo di Stefano. «A ogni ricordo, a ogni disagio, si ripeteva che tanto quella non era la sua vita, che quella gente e quelle parole scherzose erano remote da lui come un deserto, e lui era un confinato, che un giorno sarebbe tornato a casa». Vivere con distacco tutto quello che accade, compresa una storia d’amore clandestina: questa è la condizione dell’ingegnere. «Di tutta la gita aveva colto specialmente l’illusione che la sua stanza e il corpo di Elena e la spiaggia quotidiana fossero un mondo così minuto e assurdo, che bastava portarsi il pollice davanti all’occhio per nasconderlo tutto». L’illusione di un periodo di vita che si affronta ma non si vive. Lo si attraversa passivamente perché si avverte la condizione di precarietà. Inutile, in altre parole, impegnarsi troppo o immergersi troppo in una realtà a cui non si appartiene, perché poi alla fine turbinano nel vortice «come foglie spazzate i visi e i nomi di quelli che non erano là».
L’intimità di questo scritto di Pavese è testimoniata da diversi passaggi, come quest’affermazione di Stefano a un suo conoscente del paese, Giannino: «Si vive con la gente, ma è stando soli che si pensa ai fatti nostri». Stefano porta il lettore a riflettere sulla propria condizione, sulla propria presenza nel mondo. La sua è una sorta di gelosa solitudine. Il carcere ti trasforma, ti rende un «foglio di carta», fragile, introspettivo ed essenziale allo stesso momento.